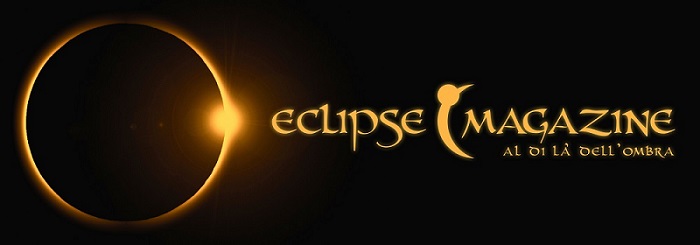- Al di là dell'ombra
Falcone e Borsellino e "Il secondo tempo"
Dibattito: La violenza sulle donne avvelena il mondo
Maggio 22, 2013Le interviste di Eclipse: Pierfrancesco Li Donni
Maggio 23, 2013 Palermo, 23 maggio 1992: strage di Capaci. Muore Giovanni Falcone. 57 giorni dopo, stessa città: Palermo, 19 luglio del 1992, verrà ucciso l’amico Paolo Borsellino. Due delitti di mafia, che hanno cambiato la storia dell’Italia. Ricordati in due opere di due giovani: “L’Agenda Rossa di Paolo Borsellino” di Giacomo Bendotti e “Il secondo tempo” di Pierfrancesco Li Donni. Entrambi raccontano l’umanità che li circonda.
Palermo, 23 maggio 1992: strage di Capaci. Muore Giovanni Falcone. 57 giorni dopo, stessa città: Palermo, 19 luglio del 1992, verrà ucciso l’amico Paolo Borsellino. Due delitti di mafia, che hanno cambiato la storia dell’Italia. Ricordati in due opere di due giovani: “L’Agenda Rossa di Paolo Borsellino” di Giacomo Bendotti e “Il secondo tempo” di Pierfrancesco Li Donni. Entrambi raccontano l’umanità che li circonda.
Si torna sempre più spesso a parlare, di un fenomeno, a volte un po’ sommerso, latente a causa dell’omertà, però ancora vivo, che ha saputo evolversi nei meccanismi: quello della mafia. Lo si tratta in maniere diverse, con ogni mezzo e strumento di comunicazione, cercando di diffondere una cultura e una sensibilizzazione al tema, per far sì che non se ne discuta solamente nelle ricorrenze degli eventi tragici, ma tutto l’anno, affinché ogni forma di manifestazione non sia strumentalizzata o non diventi un mero evento mediatico. Più fatti, meno parole. Speranza in merito è stata infusa dal discorso e dall’elezione del presidente del Senato, Pietro Grasso, che ha detto di voler istituire una nuova Commissione d’Inchiesta su tutte le Stragi irrisolte del nostro Paese. Già perché ancora molte stragi attendono che sia fatta luce sulla realtà degli avvenimenti. I parenti delle vittime chiedono giustizia, verità, chiarezza e rispetto. Umanità, in una parola. Ovvero che non si tralasci di considerare l’aspetto emotivo degli episodi, di stragi che hanno cambiato la storia italiana. Non bisogna dimenticare, ciò che avvenuto, come il fatto che a vivere questi delitti di mafia sono state persone, con i loro stati d’animo, le loro paure, la loro rabbia, il loro dolore, i loro sentimenti, che sono stati o infranti o tralasciati, mentre hanno una portata centrale. Storie di persone più che di personaggi, anche se diventati icona e simbolo della lotta per la libertà e per la democrazia. Due uomini su tutti: Giovanni Falcone, il magistrato ucciso a Capaci il 23 maggio del 1992. E Paolo Borsellino, altro magistrato assassinato a Palermo, soli 57 giorni dopo, il 19 luglio dello stesso anno. Due figure “scomode”, da eliminare poiché artefici della lotta alla mafia. Un fenomeno che, per antonomasia, si vede insediato al Sud, in Sicilia. Come se l’essere siciliano e mafioso combacino, come se abitare lì implichi direttamente di essere mafioso o complice della mafia, quasi fosse una malattia ereditaria. Quando invece vivere lì è tutt’altra cosa, convivere con un potere tirannico come quello della mafia, significa essere vittima del più grande dei delitti: la privazione di ogni forma di libertà. Ciononostante, con un buon esempio, quello siciliano è stato un popolo che ha avuto la forza per ribellarsi, ha saputo dire quel no da dove ripartire per ricostruire una minima forma di democrazia anche al Sud: soprattutto quella d’opinione. A chiederci di non dimenticare. A spiegarci cosa significhi abitare in città-roccaforte della mafia, pensando però a chi è costretto, volente e/o nolente, a trascorrere la sua esistenza in una città e in una parte del Paese che chiede di riavere il suo posto nel mondo, per così dire, di poter tornare a contare, a fornire il suo contributo. A raccontarci l’esperienza catartica di trovarsi a Palermo, in Sicilia, soprattutto dopo i delitti di Falcone e Borsellino, è un giovane regista siciliano, Pierfrancesco Li Donni. Tratta l’argomento in un documentario innovativo, girato a Palermo nel 2012: “Il secondo tempo”, un’opera che è già stata presentata ad Oriolo il 19 marzo scorso. Fuggito dalla sua terra, vi ritorna a distanza di tempo, ritrovando tutta la suggestività di una città cambiata, che sta vivendo il suo “secondo tempo”, una nuova era, quasi una nuova vita, una nuova opportunità di vedersi riconosciuto il diritto alla serenità, alla tranquillità e alla libertà di una vita non più succube, assoggettata, gestita da forze di stampo mafioso. Almeno apparentemente, poiché certe ferite non si cancellano. Palermo: 20 anni dopo le stragi.
Tanto che, nel sito, www.ilsecondotempo-ilfilm.it così viene presentato il documentario: “A Palermo la notte può essere anche una metafora a vent’anni dalle stragi di Mafia. La Palermo del Secondo Tempo è una città che avrebbe potuto essere e non è stata, ma anche una città dove bisogna capire cosa si fa quando finisce un’emergenza democratica e ricomincia la quotidianità”.
Vogliamo concludere con due frasi due questi due grandi uomini:
«La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere, non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni».
(Giovanni Falcone, in un’intervista a Raitre).
«Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri». (Paolo Borsellino).
di Barbara Conti