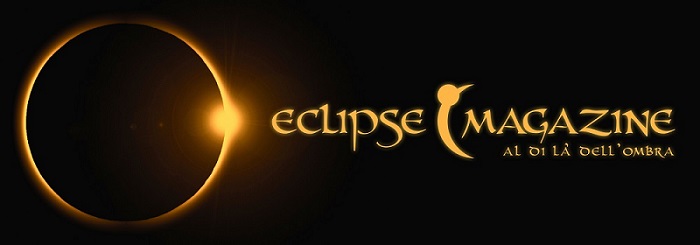- Al di là dell'ombra
Lucca a tavola
Al cinema piace il seriale
Gennaio 21, 2010test
Gennaio 21, 2010 Lucca si trova in Toscana è capoluogo di provincia e conta 85.537 anime (dati Istat, 2008).
Lucca si trova in Toscana è capoluogo di provincia e conta 85.537 anime (dati Istat, 2008).Nel medioevo era una tappa molto importante della Via Francigena grazie alla reliquia del Volto Santo custodita nel Duomo di Lucca, gioiello architettonico fondato nel VI secolo da San Frediano e poi ricostruito e modellato nei secoli.
Forse di questa città ne avrete sentito parlare per i Lucca Comics, la più importante rassegna italiana di fumettistica, per le migliaia di lumi che compongono la spettacolare processione di Santa Croce, per le sue antiche mura rinascimentali o forse per la leggenda di Lucida Mansi, affascinante nobildonna lucchese che vendette l’anima al diavolo in cambio di 30 anni di bellezza. Ma vi sono poche possibilità che ne abbiate sentito parlare per le sua gastronomia… essenziale.
Non fraintendete… A Lucca non si mangia male, è solo che la cucina lucchese è molto semplice. D’ispirazione e di origine contadina, essa si basa molto sulle carni, soprattutto quella di maiale ( del maiale un si butta via nulla!). Si avvale di ottimi ingredienti ed accompagnamenti, come l’olio ed il vino, pregiati e premiati da secoli in quel de la regione Toscana. Il ventaglio dei primi piatti e dei piatti unici, è senza dubbio più vasto rispetto a quello dei secondi. Questo è dato dal ruolo preponderante dei cereali, delle polente e delle zuppe nella gastronomia della zona. Minestra di farro, polenta con maiale e salsicce, polenta col baccalà, farinata di fagioli con il cavolo nero, minestra di ceci, Zuppa Matta e tordelli di carne (sì, con la “d”!) sono solo alcuni dei primi piatti. Tra i dolci ricordiamo il Castagnaccio (dolce a base di farina di castagne), la Torta co’ becchi (dolce a forma di corna, becchi, di pastafrolla) ed il Buccellato, forse il dolce più rappresentativo di Lucca. Difficile trovare a Lucca un posto che venda dolci, sprovvisto di Buccellato. Il nome gli deriva dal Latino buccella, ovvero boccone. Nell’antica Roma il Buccellatum era un tipo di pane circolare formato da tanti panini, i bocconi. Forma che riprese il Buccellato lucchese, dolce domenicale per antonomasia fino a pochi decenni fa. Oggi in realtà se ne trovano molti di più di forma rettangolare, a panetto, simili ad un Pan brioche non intrecciato. La sua composizione è semplice e genuina (ndr: sarà anche per questo che non piace più come una volta!). È un pane dolce con uvetta ed anice, dall’aspetto brunastro e lucido in superficie, regalatogli da copiose spennellature d’uovo. A chiunque s’addentri nella lucchesia consiglierei proprio di assaggiare questo dolce, magari accompagnato da un bicchiere di latte fresco.
Tra i secondi, meno “famosi” dei primi dicevamo, troviamo le anguille alla lucchese, i fegatelli di maiale, la Frissoglia e la Cioncia. Stiano lontani i vegetariani da quest’ultima preprazione d’altri tempi. La Cioncia è a base di testina di vitello. La carne, tagliata a listarelle, viene soffritta per poi essere servita in umido su pane bruscato. Ottima accompagnata da un contorno di fagioli.
Per chi non avesse la fortuna di addentrarsi negli affascinanti viottoli medievali lucchesi, alla ricerca di taverne e osterie, consiglio un libricino, ancora reperibile in mercatini e negozi di libri usati. “Mangiari lucchesi”, edito dalla MPF editore nel 1987. Una raccolta di ricette ad opera della classe II sezione E, della Scuola Media D. Chielini di S. Vito, negli anni 1974 e 1975. Gli allora giovani, chiesero a nonne e zie di Lucca o della piana lucchese, ricette tradizionali. Il libricino contiene più di una cinquantina di ricette tipiche, raccontate in maniera essenziale e pratica, in stile “da nonna” più che “da chef”. Proprio come la cucina lucchese, genuina, semplice e senza tanti “ghirigori”.
Per chi non avesse la fortuna di addentrarsi negli affascinanti viottoli medievali lucchesi, alla ricerca di taverne e osterie, consiglio un libricino, ancora reperibile in mercatini e negozi di libri usati. “Mangiari lucchesi”, edito dalla MPF editore nel 1987. Una raccolta di ricette ad opera della classe II sezione E, della Scuola Media D. Chielini di S. Vito, negli anni 1974 e 1975. Gli allora giovani, chiesero a nonne e zie di Lucca o della piana lucchese, ricette tradizionali. Il libricino contiene più di una cinquantina di ricette tipiche, raccontate in maniera essenziale e pratica, in stile “da nonna” più che “da chef”. Proprio come la cucina lucchese, genuina, semplice e senza tanti “ghirigori”.
Per chi volesse approfondire questi temi on-line consiglio:
Lucca a Tavola, sezione del sito Lucca Virtuale,
Lucca a Tavola, sezione del sito Lucca Virtuale,
Ricette tipiche lucchesi e della Garfagnana,
Un blog su Storia e Tradizioni lucchesi,
Buon appetito e ricordate, come dice un adagio toscano: “Chi vuol viver sano e lesto, mangi poco e ceni presto”!!!
di Giada Martinucci