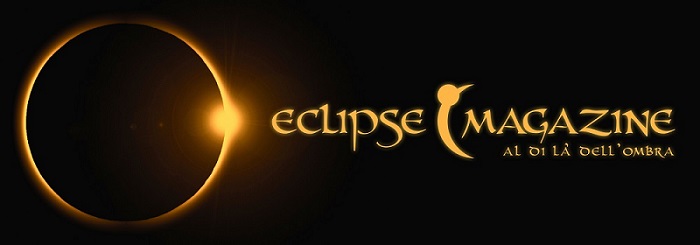- Al di là dell'ombra
Accademia della Crusca: "mancano i fondi"
David Gilmour : On An Island Tour 2006
Agosto 2, 2006Opere Prime
Dicembre 14, 2007 Il più importante punto di riferimento per le ricerche della lingua italiana, potrebbe presto vedere ridotte le proprie attività. Nata a Firenze tra il 1582 e il 1583 con il compito di “ripulire la lingua” e per iniziativa dei fiorentini Giovan Battista Deti, Anton Francesco Grazzini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini, Bastiano de’ Rossi e Lionardo Salviati, l’Accademia della Crusca deve il suo nome alle animate riunioni, chiamate scherzosamente “cruscate”, dei sei letterati fiorentini.
Il più importante punto di riferimento per le ricerche della lingua italiana, potrebbe presto vedere ridotte le proprie attività. Nata a Firenze tra il 1582 e il 1583 con il compito di “ripulire la lingua” e per iniziativa dei fiorentini Giovan Battista Deti, Anton Francesco Grazzini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini, Bastiano de’ Rossi e Lionardo Salviati, l’Accademia della Crusca deve il suo nome alle animate riunioni, chiamate scherzosamente “cruscate”, dei sei letterati fiorentini.Ma la sua importanza, la sua antica storia (l’Accademia infatti è famosa anche per il suo celebre “Vocabolario”, edito per la prima volta nel 1612 e ampliato e ripubblicato fino al 1923) e la sua fama a livello internazionale, non le bastano a garantirle un futuro all’insegna della ricerca e della formazione; c’è bisogno infatti di soldi. «Se i fondi disponibili continueranno a rimanere limitati agli attuali» dice il presidente Francesco Sabatini «l’Accademia della Crusca rischia di dover ridurre di molto i propri orizzonti». Pioggia di appelli dunque, dal presidente della Regione Toscana Riccardo Nencini, al deputato Guglielmo Picchi, dal presidente della commissione cultura del Comune di Firenze Dario Nardelli al senatore Paolo Amato, ma per Sabatini l’unica via percorribile è una legge speciale per l’Accademia: è ora d’un ente pubblico non economico, ma il problema non è tanto quello della definizione giuridica, quanto che ad ogni scadenza il governo dice che non ci sono soldi. Difficile anche la gestione della sua Biblioteca, che con i suoi 121 mila volumi è la maggiore per quanto riguarda la lingua italiana. «Una biblioteca» come precisa Sabatini «che deve essere però arricchita in continuazione». Tra le sue attività e i suoi obiettivi l’Accademia della Crusca annovera sia un’importante attività scientifica con la formazione di nuovi ricercatori nel campo della linguistica e della filologia italiana, che l’acquisizione e la diffusione nella società italiana, in particolare nella scuola, della coscienza critica della sua evoluzione attuale nel quadro degli scambi interlinguistici del mondo contemporaneo. L’Accademia infine collabora attivamente con le principali istituzioni affini di Paesi esteri e con le istituzioni governative italiane e dell’Unione Europea per la politica a favore del plurilinguismo del nostro continente.